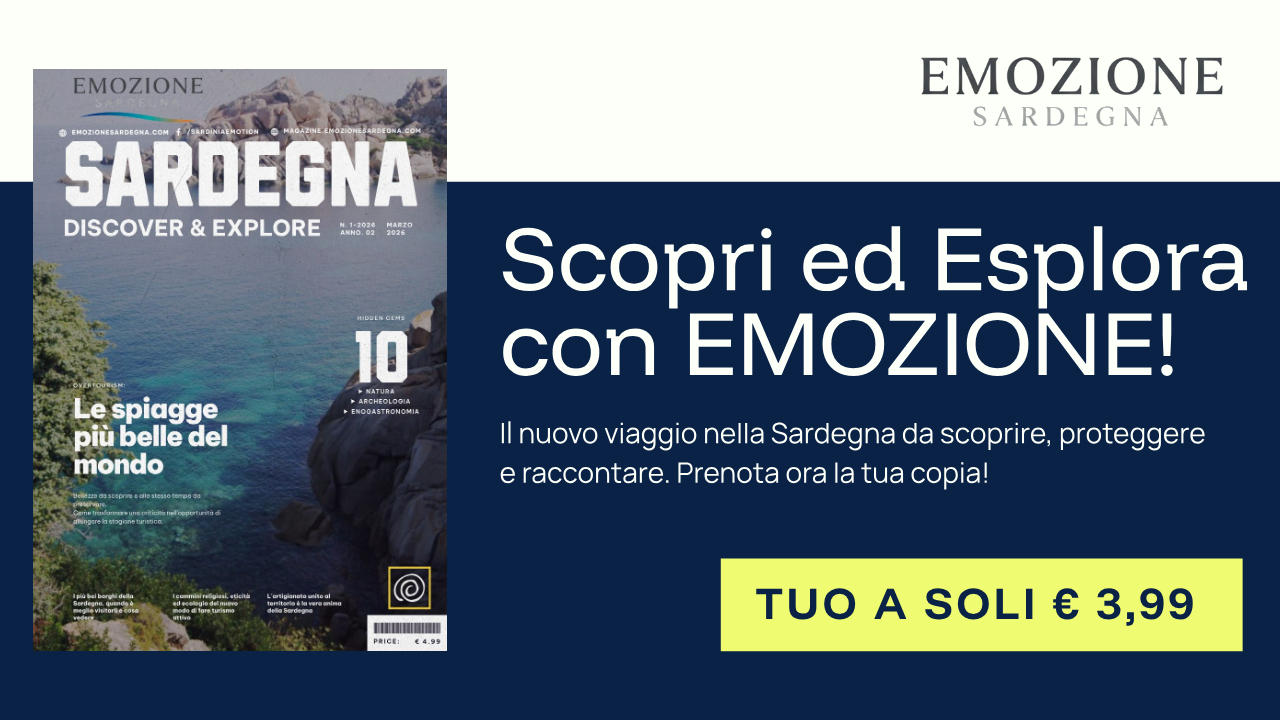Storia, privilegi e curiosità di un’eredità medievale ancora viva
Tra le pagine più controverse e allo stesso tempo affascinanti della storia sarda, spicca quella delle Sette Città Regie, un’eredità del periodo catalano-aragonese che ha segnato profondamente la struttura politica, economica e culturale dell’isola. In un tempo in cui la Sardegna era divisa in feudi e villaggi soggetti ai signori locali, solo sette città ebbero il privilegio di essere governate direttamente dal re, godendo di autonomia e di speciali diritti amministrativi e commerciali.
Origini delle Città Regie
Con l’arrivo dei Catalano-Aragonesi all’inizio del Trecento, la Sardegna fu conquistata e in gran parte infeudata, cioè assegnata ai nobili fedeli alla corona. Tuttavia, sette centri urbani rimasero “liberi da signoria” e posti sotto il governo diretto del sovrano. Queste città – Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias, Oristano e Sassari – vennero definite “Città Regie”, o “Cittades Reials”, in lingua catalana.
Essere città regia significava vantare privilegi notevoli: autonomia amministrativa, esenzione da alcune imposte feudali, diritti di mercato e di rappresentanza nel Parlamento del Regno di Sardegna. I cittadini eleggevano propri rappresentanti, i consiglieri, mentre un vicario o podestà rappresentava il sovrano per convalidare le decisioni comunali. I sindaci delle città regie partecipavano allo stamento reale, uno dei tre bracci del Parlamento sardo insieme allo stamento militare (nobiltà) e a quello ecclesiastico.
Le sette città regie in ordine cronologico
Iglesias (dal 7 giugno 1327)
Conosciuta allora come Villa di Chiesa, fu la prima città sarda a entrare nel novero delle città regie. Ricca di miniere d’argento e piombo, era un importante centro economico del Regno. Le sue strade medievali e le antiche chiese testimoniano ancora oggi la grandezza del periodo aragonese.
Cagliari (dal 25 agosto 1327)
Capitale del Regno e principale scalo marittimo, Castel de Càller (poi semplicemente Cagliari) divenne il cuore politico e amministrativo del dominio aragonese in Sardegna. Il quartiere di Castello, con le sue torri, il bastione e la cattedrale, conserva l’anima regia della città.
Sassari (dal 20 agosto 1331)
Già potente repubblica comunale nel periodo giudicale, Sàsser fu poi incorporata come città regia. Il suo statuto comunale del 1316 è tra i più antichi d’Italia e testimonia la precoce vocazione all’autonomia politica del Nord Sardegna.
Castelsardo (dal 1448)
Nata come Castel Genovese sotto i Doria, cambiò nome in Castillo Aragonés dopo la conquista aragonese, diventando città regia. Oggi Castelsardo è una perla del turismo, ma nel Quattrocento era una piazzaforte strategica sul mare, simbolo della potenza iberica nel Golfo dell’Asinara.
Oristano (dal 15 agosto 1479)
Antica capitale del Giudicato d’Arborea, dopo la sconfitta di Eleonora e la caduta dell’indipendenza giudicale entrò anch’essa sotto il controllo diretto della corona. La sua storia è profondamente legata al mito della Carta de Logu e alla resistenza sarda contro l’invasione straniera.
Bosa (dal 1499)
Elegante città fluviale, adagiata sulle sponde del Temo, Bosa divenne città regia alla fine del Quattrocento. Con il suo castello dei Malaspina e le case color pastello, rappresentava un importante nodo commerciale tra l’interno e la costa occidentale.
Alghero (dal 28 agosto 1501)
Ultima ad essere proclamata città regia, L’Alguer è forse la più nota per la sua identità catalana, tuttora viva nella lingua e nelle tradizioni. Fu ripopolata da coloni catalani dopo la conquista aragonese e divenne un centro economico e culturale di primaria importanza, oggi simbolo della Riviera del Corallo.
Il periodo sabaudo e la fine dei privilegi
Con l’arrivo dei Savoia nel XVIII secolo e la formazione del Regno di Sardegna, i privilegi delle città regie iniziarono a perdere valore. Pur mantenendo il titolo di “città”, esse persero le prerogative amministrative e fiscali che le avevano rese uniche. Tra il 1836 e il 1840, con il riscatto dei feudi, il sistema feudale fu abolito e il titolo di città divenne puramente onorifico.
In seguito, altri centri ottennero lo stesso riconoscimento – tra cui Tempio Pausania, Ozieri e Nuoro – ma senza il peso politico e istituzionale delle storiche sette città regie.
Un’eredità che vive nel presente
Oggi le Sette Città Regie della Sardegna rappresentano un itinerario di viaggio ideale per chi vuole scoprire l’isola attraverso la storia, l’arte e la cultura. Ognuna racconta una parte diversa del mosaico sardo: dai bastioni catalani di Alghero ai vicoli medievali di Iglesias, dal fascino fluviale di Bosa alle mura maestose di Castelsardo, passando per la solennità di Cagliari, l’eleganza di Oristano e la vivacità culturale di Sassari.
Visitare queste città significa ripercorrere sette secoli di storia, tra influenze spagnole, giudicali e sabaude, e comprendere come l’identità sarda sia il risultato di una straordinaria stratificazione di popoli e culture.
Non tutti sanno che…
- Le sette città regie avevano il diritto di inviare i propri rappresentanti al Parlamento del Regno di Sardegna, cosa che le rendeva vere protagoniste della vita politica isolana.
- Ad Alghero si parla ancora oggi il catalano algherese, riconosciuto come lingua minoritaria tutelata.
- Bosa è l’unica città sarda attraversata da un fiume navigabile, il Temo.
- Iglesias deve il suo nome alle tante chiese presenti nel centro storico (oltre 20).
- Sassari conserva ancora tratti del suo antico statuto comunale, uno dei più antichi d’Europa.
- Il castello dei Doria a Castelsardo è oggi sede del Museo dell’Intreccio Mediterraneo, che celebra l’arte antica della lavorazione delle fibre naturali.
- Ad Oristano, ogni anno, la giostra equestre della Sartiglia ricorda la tradizione cavalleresca dei tempi giudicali e regali.